Fingiti ignorante

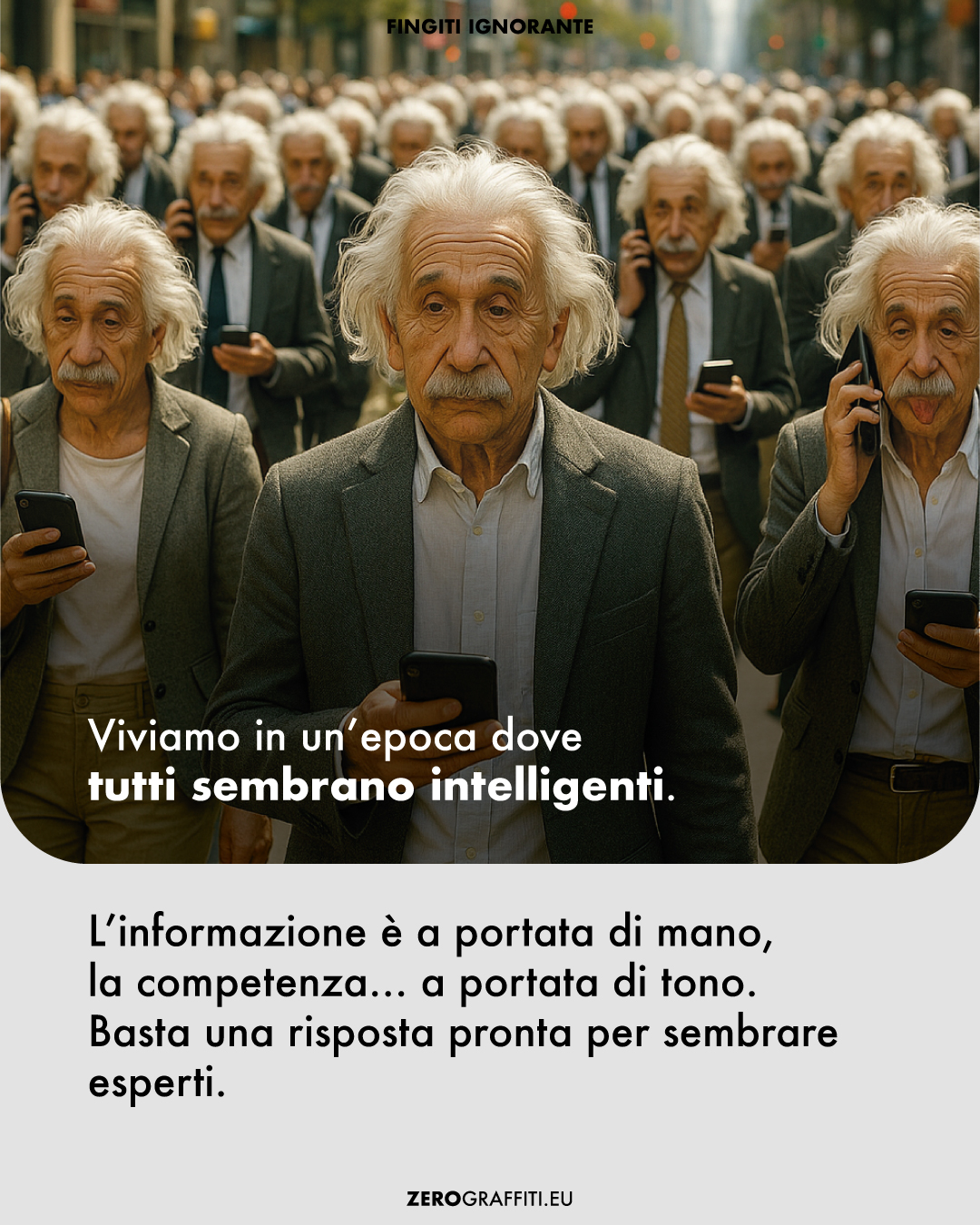

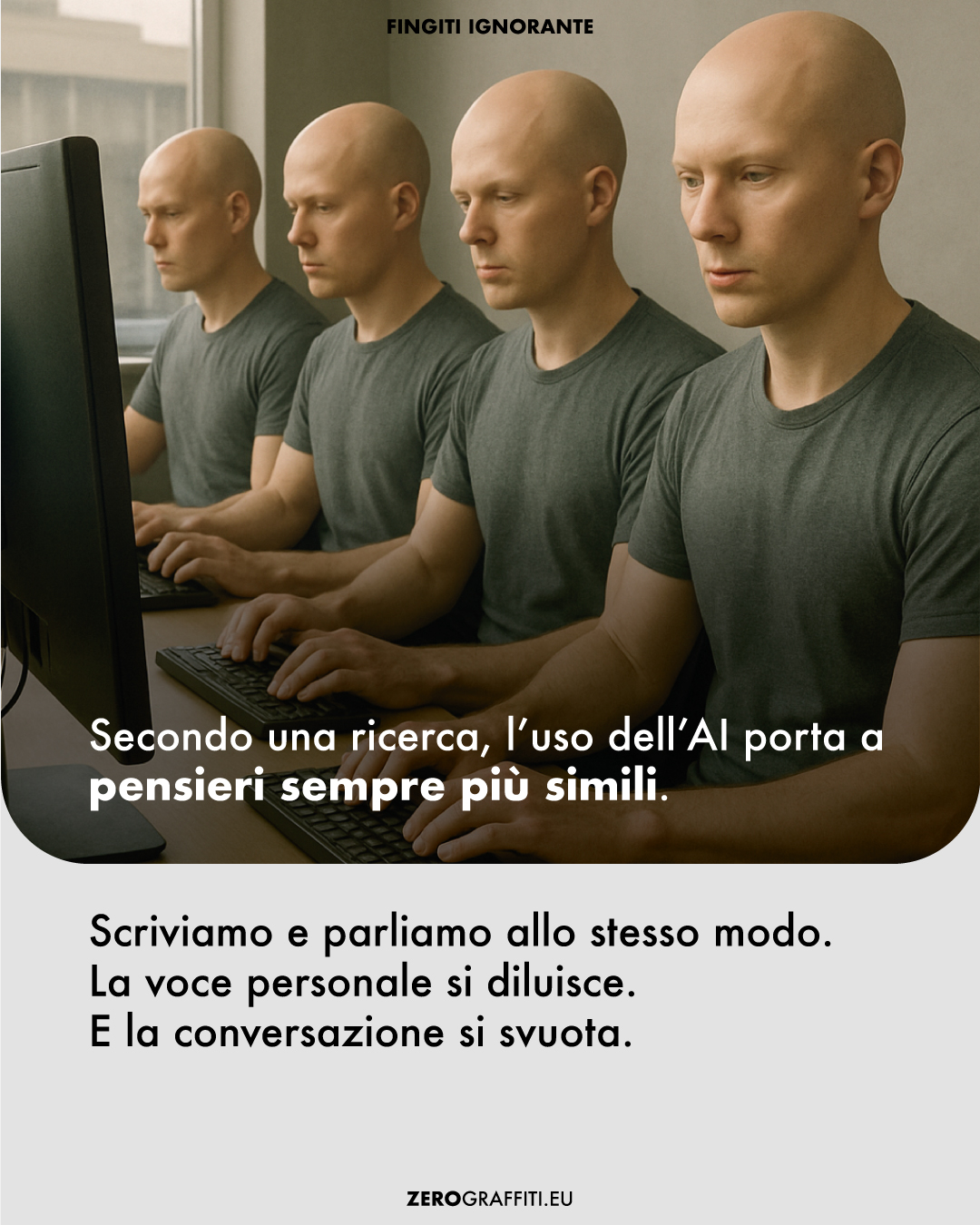
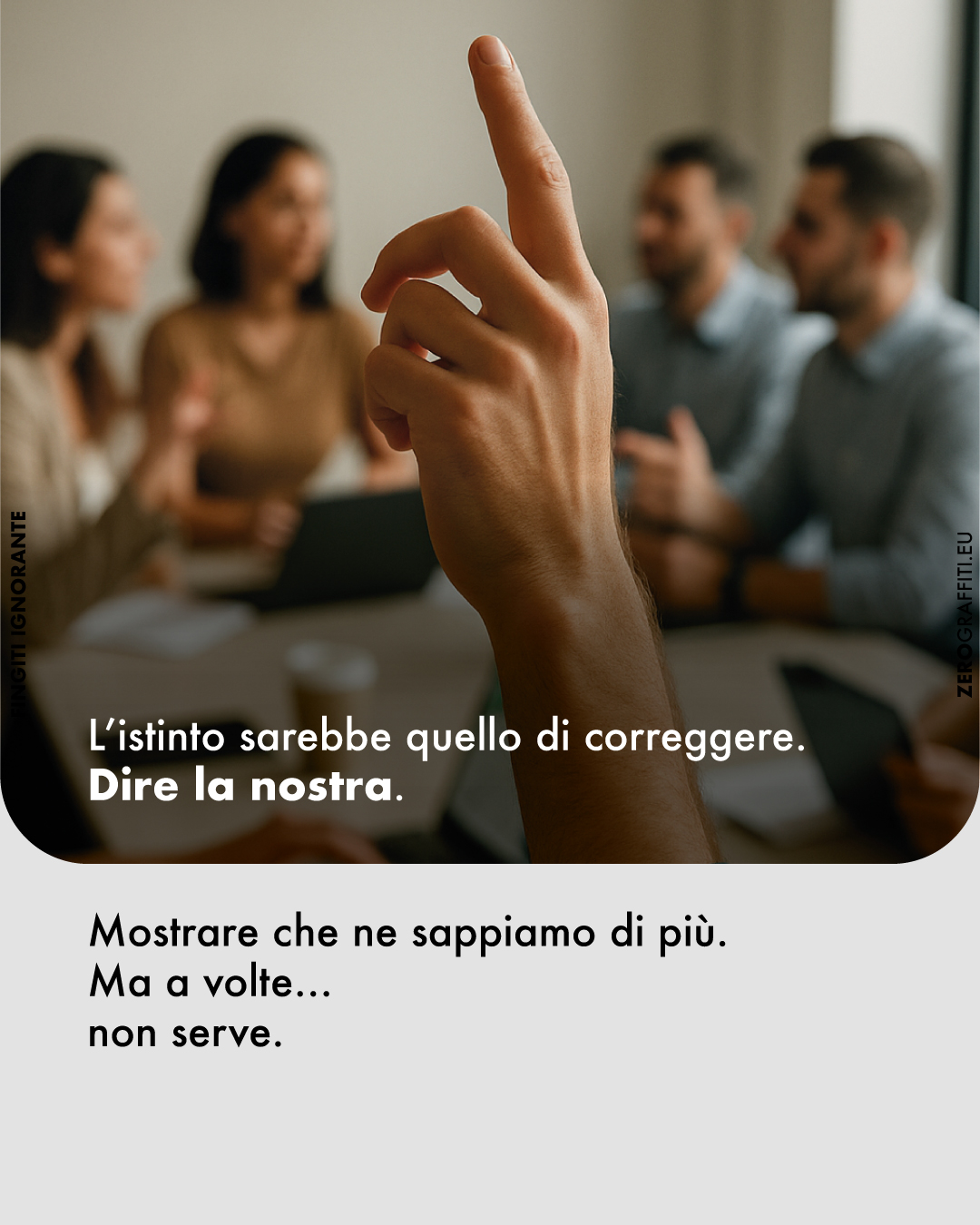
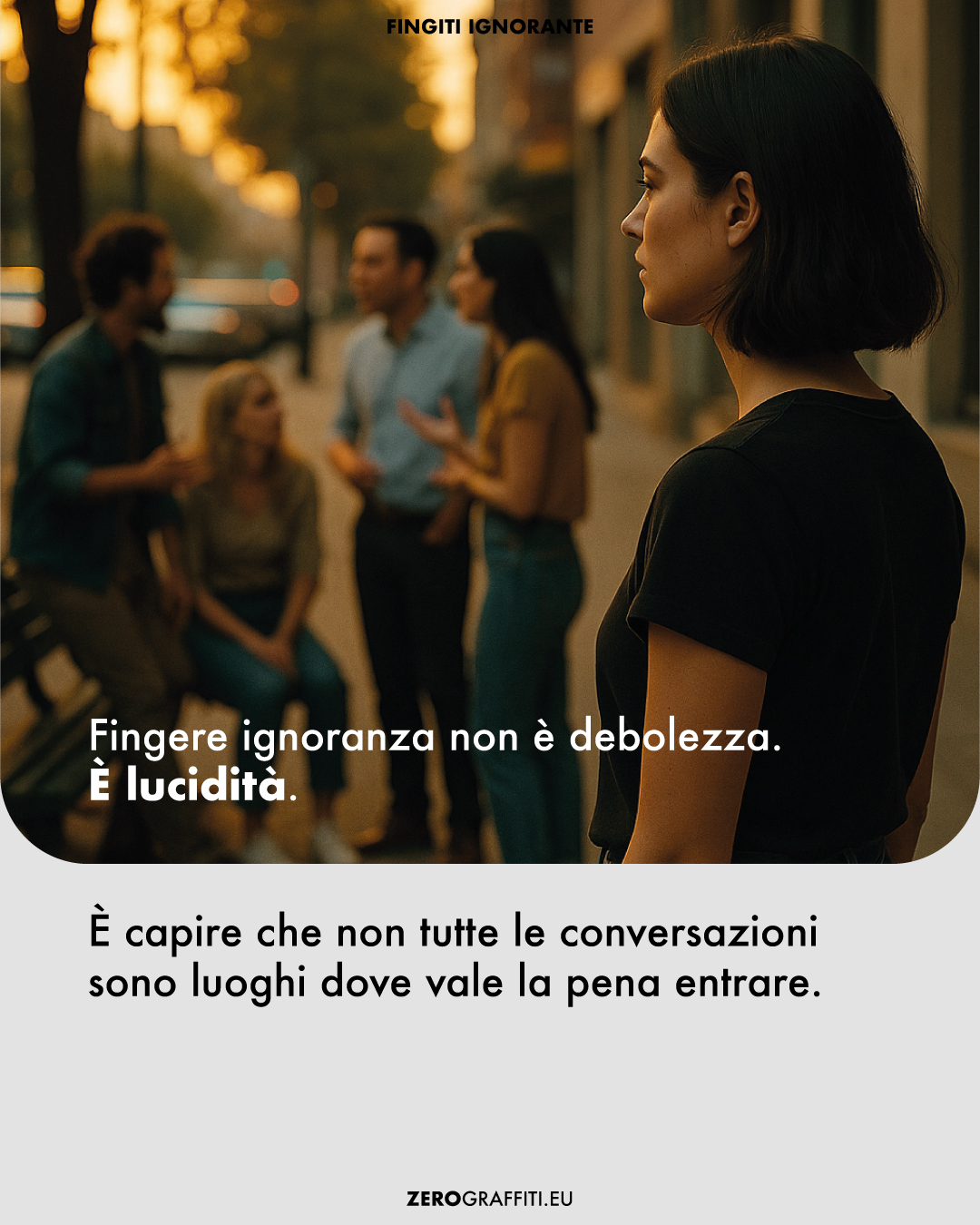
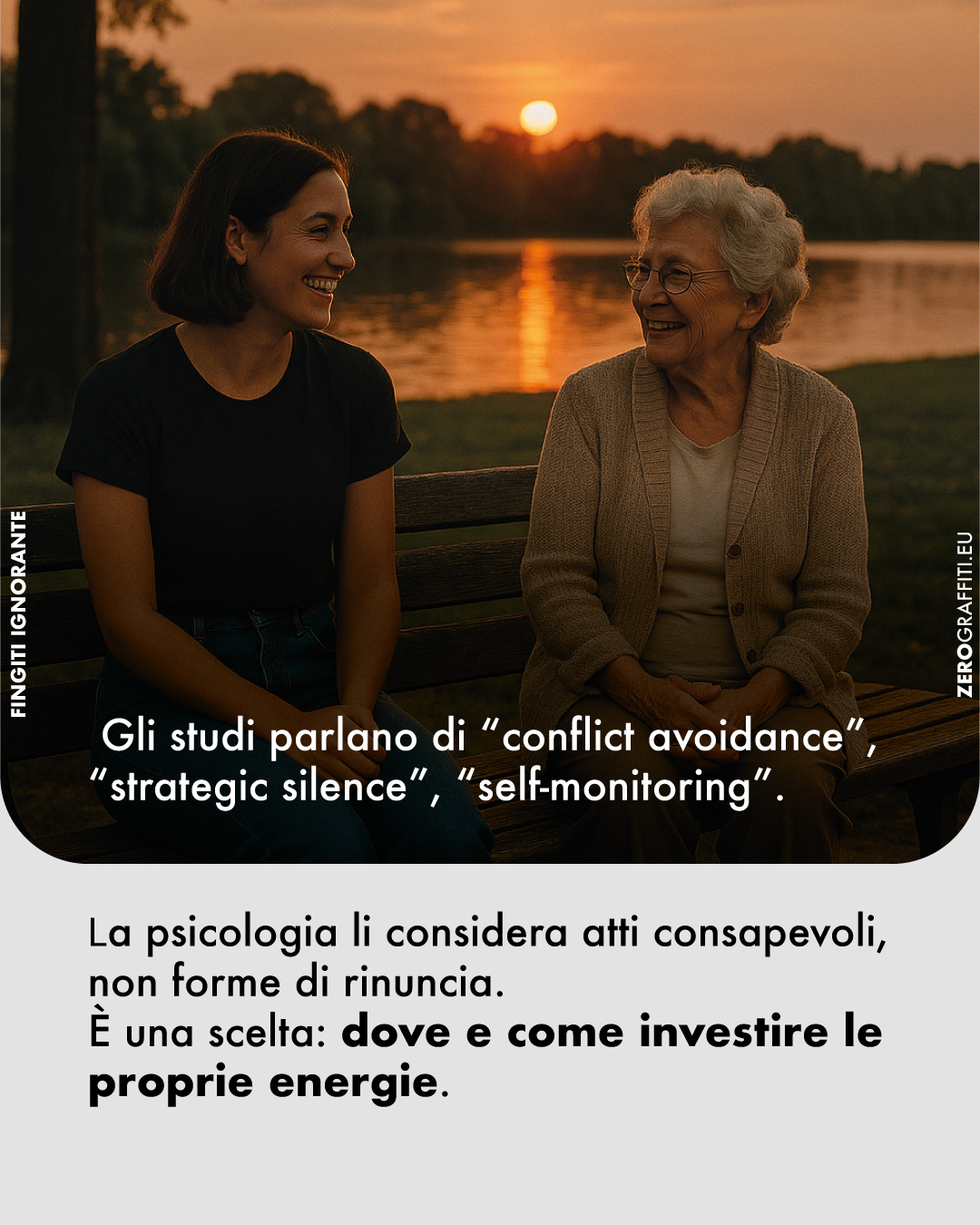

Nel rumore delle opinioni, c’è chi sceglie di tacere.
E non perché non ha nulla da dire.
C’è una scena che si ripete ogni giorno, ovunque: un bar, una pausa pranzo, un tavolo condiviso. Qualcuno snocciola aneddoti, numeri, spiegazioni che sembrano usciti da un documentario. Un altro lo contraddice, ma non per aggiungere: per avere ragione. Tu stai in mezzo. Sai qualcosa, forse ne sai anche di più. Ma decidi di non intervenire. Fingiti ignorante. Non per debolezza, ma per lucidità.
In un’epoca dove sembriamo tutti intelligenti
Mai come oggi la conoscenza è diventata accessibile, confezionata, performativa. Abbiamo sempre una risposta pronta. Un prompt all’AI, un video da 60 secondi, un articolo letto a metà. Sappiamo tutto. O almeno così sembra.
Il problema è che questa intelligenza rapida non nasce dall’ascolto, ma dal controllo. Serve a vincere discussioni, non ad aprirle. Serve a farsi ascoltare, non ad ascoltare.
Uno studio pubblicato su The New Yorker analizza proprio questa dinamica: l’uso massivo di AI nei testi tende a omogeneizzare il pensiero. Le persone finiscono per scrivere – e parlare – tutte nello stesso modo, perdendo autenticità, voce personale, spirito critico (The New Yorker, 2024).
Conversazioni o monologhi alternati?
Secondo una ricerca della Cornell University, usare risposte generate automaticamente – anche se intelligenti e gentili – riduce la percezione di autenticità nell’interlocutore. In altre parole: se ti sembra che l’altro non stia pensando davvero, smetti di fidarti (Cornell Chronicle, 2023).
E allora le conversazioni diventano schermaglie. Frasi già pronte, citazioni da sfoderare, toni da opinionisti. Ma nessuno ascolta. Nessuno costruisce davvero sull’altro. E chi prova a farlo, spesso, si stanca e si ritira.
Il sapere senza pensiero
C’è un altro dato che rafforza questo scenario: uno studio pubblicato su MDPI mostra che un uso intenso dell’AI tende a ridurre le capacità di pensiero critico. Non perché l’AI sia dannosa, ma perché ci abitua a non riflettere. A delegare. A rispondere senza dubitare (MDPI, 2024).
E se non dubiti, non ascolti. Se non ascolti, non impari.
Fingere ignoranza: scelta, non rinuncia
Davanti a tutto questo, c’è chi sceglie il contrario: il silenzio.
Non per sottomissione, ma per strategia.
In psicologia esistono concetti che aiutano a leggere questo comportamento:
•Conflict avoidance: evitare lo scontro diretto quando non è costruttivo.
•Strategic silence: tacere per creare uno spazio riflessivo o neutralizzare tensioni.
•High self-monitoring (Mark Snyder): adattare ciò che si mostra per non invadere l’altro.
•Knowledge hiding: trattenere la propria competenza per non compromettere l’interazione.
•Self-silencing (Ohio State): scegliere il silenzio quando l’ambiente non è sicuro per esprimersi.
Fingere ignoranza può quindi diventare un atto deliberato. Un modo per non giocare al gioco del “chi ha ragione”. Un modo per non regalare energia a chi vuole solo imporsi. Un modo, in fondo, per ricordare a sé stessi che si può sapere qualcosa… senza bisogno di dimostrarlo.
La nuova eleganza del non dire
In un mondo che corre a mostrarsi sempre più sveglio, preparato, aggiornato, la vera lucidità sta forse nell’ombra.
Nel saper tacere.
Nel saper ascoltare.
Nel lasciare che l’altro esaurisca la sua recita mentre tu – senza palco – continui a imparare, a osservare, a esistere.
Come si diceva una volta:
impara l’arte e mettila da parte.
Non è più tempo di sfoggiare.
È tempo di scegliere dove vale la pena spendere le proprie energie.
